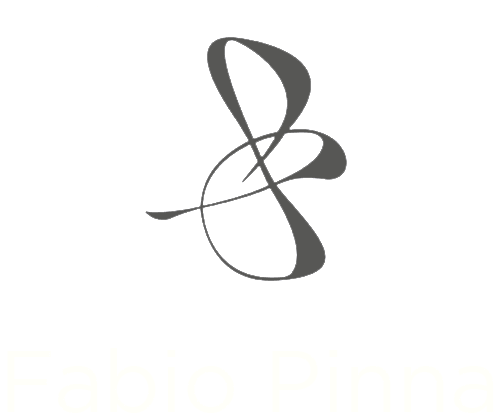Quel giorno partisti quasi senza deciderlo. D’istinto. Prendesti con te poche cose, contate, sapevi che non saresti potuta stare via per molto. Tra quelle poche cose c’era un sorriso ristrutturato più volte, una quarta di marcia per le partenze, una tenerezza in coppia con una debolezza, una collaudata stanchezza in coppia con un eccesso di velocità non multabile, una cartella piena di un vuoto proprio vuoto, un eccesso di normalità. Quella normalità che fa rima con tutto, cresce e ci segue dappertutto, e prima o poi si fa odiare da chiunque. Dopo larghi giri programma la morte dei nostri sogni, dicono.
La destinazione è lontana, dal tuo punto di partenza molti percorsi portano alla tua meta. Te ne bastava uno qualsiasi. Anche solo una direzione. Certi posti si trovano con un orientamento speciale, è il cuore a fare da bussola. Bip del cellulare, girasti la chiave nel quadro senza degnare di uno sguardo il display, jeans e maglietta non impeccabili, corpo asciutto con qualche bel tornante e occhi stanchi di non trovare bellezza da guardare. Occhiali da sole. Pioggia. Cose da lasciare, tante, come è per tutti. Cose che non si lasciano con un ciao liscio.
Ma con la mente, di nascosto, a volte sì. Quella volta non è stata di nascosto. “Devi pensare a te per una volta”, ripetevi con le mani alle dieci e dieci sul volante. Ora, dopo tanto tempo, dalla prima patente di carta, dal monolocale al lavoro a tempo determinato, dal matrimonio al primo figlio e poi “benvenuta Alice” e “che bella famiglia che siete” c’è pure il bassotto, ora ti fai da parte, dall’appartamento in periferia alla seconda macchina. Ora ci sono le lacrime che solo lo specchio del bagno conosce. Ti senti un appena. Dopo tanto tempo e buchi da tutte le parti da cui ti esce tutto l’ossigeno, buchi come quelli di una gomma di bicicletta che sta a terra e che con un cerchione bello duro che può ancora portarti ovunque. Tu.
In quel momento avresti voluto tornare a sentire te di nuovo e non più solo gli altri, sentire come sei davvero tu in quel preciso istante in cui ti senti viva. Perché non te lo ricordi proprio più, la memoria lotta con un presente troppo rumoroso. Nella corsia di destra, prudente, già sgelavi. I cartelli stradali dei posti che incroci suggerivano lettere che servono per parole da trovare. Anticipano un’altra storia itinerante, rassicurante e dispersa. Da vivere. Chilometri, centinaia. Il collo dolorante. Ti senti durante. Ed è un qualcosa che va, che regge.
La seconda a sinistra. Forse. Proseguire in questa direzione per altri non so. Se ci ripensi sorridi. Luce, notte. Stazione di servizio sporche, strade nuove. Una corsia ti sembravano due. La libertà fa questo effetto, fa delle cose normali che nel nostro percorso abbiamo pian piano rimpicciolito delle cose grandi. Abbastanza spaziose per tutto. Per tutti. Anche per te.
Sono le sei e quattro minuti del mattino, puoi permetterti di scalare marcia e proseguire a passo d’uomo. Sei quasi arrivata. Una casetta in legno sulla destra, si scende dritto verso la spiaggia. L’oceano. Abbastanza spazioso per tutti. Prendi la cartella di vuoto, controlli nello specchietto che nessuno ti rovini quel momento, sistemi i capelli. Fai scendere il finestrino. L’aria fredda si incolla subito a ogni cosa. Un bel respiro. Chiudi il finestrino. Esci dall’auto senza chiuderla. Il rumore della risacca è magnetico. Ma non è quella la tua destinazione.
Sali gli scalini, apri la porta senza la chiave come i supereroi. Fortunatamente non era chiusa a chiave. I tuoi occhi cercano nell’oscurità. Si intravedono delle forme familiari. Tavolo. Sedie. Arredamenti. Accantonamenti. Metri di penombra e poi. Nonostante tutto, pensi, ne è valsa la pena. Il viaggio, lasciare qualcuno in pena, pagare il pedaggio del coraggio. L’orologio si sgancia scivolando dal polso, il vetro del quadrante si spacca sul pavimento di legno spesso e le lancette si fermano. Un tempo finisce. Una sveglia da qualche parte nella casa inizia a suonare. Suona. Suona. Ben presto l’intensità si fa sempre minore. Le batterie si sono scaricate evidentemente. Un tempo finisce.
C’è una piccola finestra dritta sull’orizzonte. Non puoi non notarla, luce ti inonda. Ti meravigli. Il primo pensiero, guardando di fuori, è che sicuramente l’oceano si apprezza di più visto da un piccolo rettangolo. Non c’è dubbio. Da lì ci si può concentrare su un punto preciso, ti sale in mente un reflusso di libertà. E si può navigare, nuotare, volare nel proprio pezzo di oceano, di libertà, senza essere visti. Da quel quadrato. Cambiare tutto dentro senza cambiare niente fuori. Basta voltare la testa. Avvicinarsi meglio ai vetri.
“Tu resti la mia finestra sull’oceano”, bisbigli. Sì, dici a me. Poi prendi un bel respiro e lasci un bel sospiro.
Ho occhi pieni del viaggio che hai fatto, di mai che hai appena portato e di un sottile velo di oceano. Abbasso gli occhi, non mi sento necessario e neppure da dimenticare. Esco da tutte le brutte versioni di me. Esco dal mio dapperniente. “Ora sei qui, qui è il posto giusto” ti dico.
Forse neppure mi senti. Fissi l’oceano attraverso i vetri della mia anima. Voli, navighi, o stai facendo surf. In ogni caso ti senti viva. E quella è la tua libertà personale. Non sarà di altri.
Carezzi con gratitudine i vetri della mia anima. Ci vedi attraverso. Cambia tutto dentro e non cambia niente fuori. Apri, chiudi. Si è fatto tardi, cerchi le chiavi dell’auto. Sono da qualche parte nella cartella che nel frattempo si è riempita. Ti senti oltre.